Caro uomo
- Margherita
- 13 giu 2025
- Tempo di lettura: 5 min
Aggiornamento: 26 lug 2025

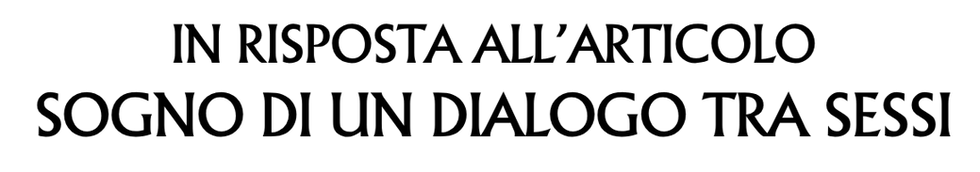
Caro uomo,
ho letto con attenzione, interesse e una certa tenerezza il tuo accorato appello al dialogo costruttivo fra i sessi. C’è tanto di buono e saggio in ciò che scrivi; il tuo ragionamento è sensato, pacato, impeccabile, direi. Ma è proprio nella ragionevolezza che risiede il suo maggior difetto, quel non so che di irritante che fa venir voglia di urlare e dire al diavolo la ragione e avanti con la passione. Perché proprio di mancanza di passione si tratta. Troppa testa e poca pancia. Toni bassi, analitici, miti, qua e là spauriti. Pronto a fare un passo indietro al primo accenno di aggressività, al primo rifiuto, al minimo alzarsi dei toni.
Un po’ ti capisco. Tu sei un giovane maschio nel mezzo di un faticoso percorso di destrutturazione e ricostruzione. Ti muovi incerto fra vecchi e nuovi paradigmi, fra antichi pregiudizi seminascosti sotto la cenere ma pronti a riprendere vita e vigore, e nuovi assetti mentali ancora non pienamente introiettati, permanentemente minacciati da una quotidianità spesso ben diversa dall’immagine illuminata e moderna che ci piace proiettare della nostra società.
Per me è diverso. Io sono una matura signora nata e cresciuta quando il patriarcato vigeva e regnava non solo nelle teste degli uomini (e di molte donne) ma nei codici legali e nelle prassi istituzionali, politiche e aziendali della nostra Repubblica.
Sono una di quelle che, appartenendo a una famiglia relativamente aperta e all’avanguardia, ha creduto a lungo che l’essere donna non costituisse un ostacolo ma un privilegio, e che la parità di genere esistesse in natura, semplicemente perché era giusto che così fosse.
Con il tempo, con gli anni, ho imparato a mie spese che poco o nulla di ciò che io davo per scontato e naturalmente acquisito lo era in realtà.
Ho scoperto di essere nata in anni in cui, alle donne, era precluso l’accesso in magistratura in base a una legge del 1919 che vietava al sesso femminile qualunque ufficio pubblico di natura giurisdizionale. Il divieto era motivato dal fatto che le donne non fossero adatte a svolgere ruoli che richiedevano autorità e fermezza e non fossero strutturalmente preparate ad affrontare il peso di una responsabilità come quella insita nella figura del magistrato. La legge in questione, che violava però l’articolo 51 della Costituzione — quello che sancisce la parità fra i sessi — fu abrogata solo nel 1963, e si dovette attendere il 1965 perché le donne fossero ammesse, finalmente, al concorso per magistrati. Ammesse, sì, ma con riserva, sospetto, paternalistica benevolenza e qualche risatina di troppo sull’incontrollata emotività pronta ad esplodere “in quei giorni lì”.
Sono diventata adolescente, caro giovane uomo. Erano anni in cui il codice di famiglia, fino al 1975, sanciva la gerarchia superiore del maschio sulla femmina e l’obbligo di quest’ultima di obbedire al capofamiglia, relegandola in uno stato infantile perenne, comodo quanto maledetto.
Nel periodo in cui scoprivo la sessualità, si auspicava che una donna arrivasse vergine al matrimonio; gli anticoncezionali erano stati da poco – nel 1971 – resi legali; non ci si vergognava ad affermare che “l’uomo è cacciatore e ha bisogni che non si possono reprimere”; l’aborto era reato e, per le ragazze che per ignoranza, incuria o semplice sfortuna restavano incinte, esisteva solo la strada della clandestinità e il rischio di morire di setticemia o di emorragia interna.
Sono cresciuta in un’Italia in cui era normale parlare di matrimonio riparatore, e in cui il codice penale contemplava il “delitto d’onore”, cancellato con clamore solo nel 1981. Un reato che implicava una pena da 2 a 7 anni (da due a sette, hai letto bene) per il coniuge, il padre o il fratello che avessero deciso di rimediare con un omicidio all’offesa inflitta al buon nome della famiglia. Offesa che di norma consisteva nel mantenere rapporti carnali con una donna della suddetta famiglia.
E che dire dello stupro? Era frequente, era roba di routine. Non era reato contro la persona – ché una donna, sotto sotto, non è persona fatta e compiuta – era reato contro la morale. Morale e onore, le due parole magiche del mondo patriarcale, fino all’altro ieri. Perché lo stupro, caro maschio bene intenzionato, è rimasto delitto contro la morale fino al 1996, quando Berlusconi aveva già avviato la sua sciagurata rivoluzione dei costumi, il suo “miracolo italiano”, quando la Prima Repubblica era già andata in frantumi spazzata via dal tintinnare delle manette e da un vortice di mazzette.
Nel mondo che ho conosciuto nella mia gioventù, una donna veniva stuprata due volte: la prima quando la violentavano – possibilmente in branco, o in famiglia; la seconda in tribunale – se aveva il coraggio di denunciare – per mano degli avvocati degli imputati e delle insinuazioni della stampa: in fondo te la sei cercata, lo hai provocato, sei stata condiscendente, non ti sei ribellata a sufficienza, hai voluto essere libera e ne hai pagato il prezzo.

E poi, mano a mano, è venuto il resto: Tina Anselmi, prima donna ministro nel 1976; Antonella Celletti, prima donna comandante e pilota di aerei di linea nel 1989; Fernanda Contri, prima donna giudice costituzionale nel 1996; Debora Corbi, prima donna ammessa nell’esercito nel 2000.
Ma mentre tutto questo accadeva, mentre l’Italia cambiava, noi giovani e meno giovani sbattevamo la testa ogni giorno contro quel maledetto tetto di cristallo che ci impediva di crescere, di emergere, di arrivare dove volevamo e avevamo il diritto di essere, circondate da una straniante finzione di uguaglianza dietro la quale gli uomini si nascondevano per sentirsi al sicuro, in pace con la coscienza, continuando a godere del loro privilegio, dei loro diritti acquisiti alla nascita, del loro status di benedetti dal destino e dall’anatomia.
E mentre masticavamo ingiustizie, ingoiavamo molestie e frustrazioni, eccoci lì: donne libere e liberate, oppresse dal nostro senso di colpa per non essere capaci di adempiere pienamente al nostro ruolo di angeli custodi, devote vestali del focolare domestico, sacre ancelle dell’accudimento.
Quale uomo sarebbe in grado di sopportare tanto, ogni giorno della vita? Quanto silenzioso eroismo ci vuole per non arrendersi, per non perdere la consapevolezza di ciò che si è, per non accumulare rabbia, rancore e sospetto? Quanti uomini accetterebbero di essere messi alla prova continuamente come se tutto fosse sempre da dimostrare, e un minimo passo falso pronto a farti precipitare giù, ai piedi della montagna, senza poter mai arrivare alla cima, in una perpetua reiterazione del mito di Sisifo?
E per una, dieci, cento che ce la fanno, quante, troppe restano indietro? Quante si rassegnano, quante rinunciano?
Dici che non ci dobbiamo incazzare? Pensi sia giusto chiederci di sorridere e accogliere? Credi sia facile festeggiare i tuoi lodevoli sforzi, i tuoi piccoli progressi, quando i nostri sono stati spesso ignorati, sbeffeggiati o peggio puniti?
Hai capito adesso perché a volte le cose con noi sono così difficili? Riesci a immedesimarti per un attimo in chi ha fatto della frustrazione un esercizio quotidiano? Non in una pericolosa femminista, ma in una comunissima femmina come me. Una nata convinta di avere il mondo in pugno e diventata vecchia sapendo che il lavoro è appena iniziato, che in pugno non abbiamo nulla, che ogni conquista va difesa con le unghie e con i denti perché non è per sempre, che la fatica di essere donna in un mondo – ahimè – ancora di uomini – è immensa e non può essere descritta.






Commenti